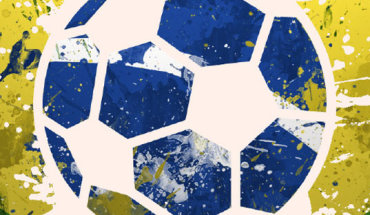Accadde un giorno di quasi un secolo fa che una squadra di baseball del Ku Klux Klan, proprio quell’organizzazione che univa ideali razzisti e di supremazia di una razza bianca, in una domenica di fine giugno del 1925 si ritrovò a incrociare il campo con i Wichita Monrovians che, come suggerisce il nome ispirato alla capitale dello stato africano della Liberia, era composta interamente da giocatori afroamericani. Una circostanza singolare, certo, e che destava una qualche apprensione anche sulla stampa locale, dati gli avvisi di non portare nessun oggetto atto a offendere pena il sequestro all’entrata. E tuttavia un incontro ci fu, si disputò a Wichita, Kansas, i Monrovians si aggiudicarono il match e i due arbitri incaricati di gestire la partita in maniera imparziale furono due cattolici bianchi, “Irish” Garrety e Dan Dwyer.
Ma questo è tutto quello che sappiamo. Perché i giornali locali, il giorno successivo, sotto al titolo Monrovians beat KKK, non dedicarono che pochi cenni alla partita, in mezzo ad una pagina che copriva l’intera giornata del baseball “bianco”.
Perché ha avuto luogo il match? Chi l’ha organizzato? Cosa cercavano di ottenere con questa partita le due squadre? Quesiti che purtroppo resteranno irrisolti.
Se il fatto che una squadra composta da giocatori afroamericani possa incontrarne una del KKK ci può fare interrogare sulle cosiddette relazioni razziali negli USA degli anni Venti, in un periodo di stragi e di una segregazione che coinvolgeva anche il mondo sportivo, l’esistenza stessa di squadre locali affiliate al KKK appare perlomeno strana, dato che, proprio in Kansas, la corte suprema aveva ufficialmente bandito l’organizzazione solo che pochi mesi prima del match in questione.
Tra il 1915 e il 1940 si fa rientrare quella che è stata definita la seconda fase del Ku Klux Klan, dopo una prima stagione sul finire dell’Ottocento come confraternita di ex militari dell’esercito degli Stati Confederati. Negli anni Venti del Novecento contava più di 4 milioni di adepti e l’utilizzo dello sport poteva essere una base di legittimazione.
Il baseball, in particolare, in quegli anni stava vivendo il momento di maggiore popolarità. La copertura della stampa si stava ampliando, si giocava nei parchi giochi e nelle scuole, veniva celebrato in canzoni e spettacoli e spesso arrivava nelle sale cinematografiche. Un entusiasmo che andava oltre la Major League, arrivando a influenzare i campionati locali, sempre più partecipati e seguiti.
Le minoranze in cerca di legittimazione che si gettavano nella sport erano diverse. Alle squadre afroamericane era dedicato ovviamente un torneo a parte; ebrei, mormoni e chiese locali formavano le proprie squadre e le iscrivevano ai campionati. Il KKK fece lo stesso.
La partecipazione allo sport poteva avere diversi gradi. Poteva accadere che due squadre del KKK si incontrassero durante qualche ricorrenza e disputassero una partita in maniera amatoriale. Poteva anche accadere che una squadra affiliata incontrasse una compagine non affiliata in maniera non ufficiale, come nel caso di Wichita.
Ma ben più interessante è notare la presenza di squadre del Ku Klux Klan in regolari campionati di baseball, entrando quindi ufficialmente nello sport “mainstream” americano.
Le prime squadre nacquero nell’Indiana, in Texas, nelle città di Atlanta, di Los Angeles, di Washington DC, iscritte la maggior parte delle volte in campionati cittadini. Squadre che rimasero in attività per pochi anni e che iniziarono a sparire verso la fine del decennio, di pari passo col declino dell’organizzazione, venendo in poco tempo dimenticate.
Restano però le cronache e i tabellini delle partite, uscite il giorno successivo sui giornali. Poche parole a commento di gesta sportive ma che mettono in evidenza due aspetti, se letti secondo quello che dicono e non dicono.
Da una parte questi resoconti ci dicono troppo: quasi sempre il nome di chi segnava il punto finiva stampato per intero sul giornale, un’anomalia se pensiamo a un’organizzazione che si supponeva segreta: un impero non così invisibile come diceva di essere.
Dall’altra queste cronache sono puramente sportive, nessun cenno alle altre “attività” della società segreta o che metta in relazione i due piani.
Le squadre del Klan non destavano particolare attenzione, non collezionavano grossi titoli sui giornali: un inserimento nel mondo sportivo che non suscitava alcun commento. E questo è forse il dato più preoccupante, quanto la presenza del Klan fosse ritenuta normale nello sport e nella vita quotidiana americana, un semplice filo nell’intreccio del tessuto della società americana.
Del resto, a pensarci bene, i giocatori in campo, anche gli affiliati al KKK, utilizzavano tutti lo stesso tipo di divisa. L’unico ad avere il volto un po’ coperto era, com’è d’uso, il ricevitore. Tutto alla luce del sole, in barba alla segretezza delle parate in cappuccio.
Ultimi post di Simone Tallone (vedi tutti)
- Di cosa parliamo quando parliamo di bici | intervista con Andrea Viola - 19 febbraio 2020
- Ku Klux Klan. Un impero (poco) invisibile - 2 dicembre 2019
- Spingi me sennò bestemmio | di Marco Pastonesi - 17 gennaio 2019
- Cavalli di razza | di John Jeremiah Sullivan - 11 gennaio 2019
- Boxe populaire – pugni rosso sangue - 20 febbraio 2018